Edoardo Sanguineti ci ha abbandonato.
Figlio unico di Giovanni, impiegato di banca, nato a Chiavari e di Giuseppina Cocchi torinese, si trasferì all’età di quattro anni a Torino, città nella quale il padre aveva trovato un nuovo impiego come amministratore cassiere presso la tipografia Doyen & Marchisio. Era ancora bambino quando, durante una normale visita di controllo, gli venne diagnosticata una grave malattia cardiaca. La diagnosi si rivelò in seguito errata ma questo episodio ha condizionato per lungo tempo lo stile di vita del poeta.
A Torino abita presso uno zio di Edoardo, Luigi Cocchi, musicista e musicologo, che aveva conosciuto Gobetti e Gramsci e aveva collaborato alla rivista L’Ordine Nuovo e che sarà il primo punto di riferimento per la formazione del giovane. A Bordighera, dove il giovane trascorre le vacanze estive, Edoardo frequenta il cugino Angelo Cervetto, appassionato di musica che gli trasmette la passione per il jazz. Nel frattempo, in seguito alla pertosse che aveva contratto, il giovanissimo Edoardo viene visitato da uno specialista che individua l’errore diagnostico del quale era stato vittima. Edoardo è sanissimo e da quel momento deve fare intensi esercizi fisici per recuperare il tono muscolare. Ginnastica, bicicletta, tennis saranno da quel momento gli sport che dovrà intensamente affiancare allo studio anche se deve rinunciare alla sua primaria ispirazione: quella di dedicarsi alla danza.
1946-1950: gli anni del Liceo
Nel 1946 Edoardo si iscrive al Liceo Classico Massimo d’Azeglio e avrà come insegnante di italiano Luigi Vigliani. A lui dedicherà il saggio su Gozzano e gli farà leggere alcune poesie che saranno in seguito parte di Laborintus. In terza liceo, Sanguineti avrà come docente di storia e filosofia Albino Galvano, pittore, critico, storico d’arte, filosofo amante della psicanalisi e interessato alle avanguardie. In questi anni il giovane frequenta il mondo “culturale” torinese, si reca a mostre, ascolta concerti, conosce la pittrice dell’avanguardia Carol Rama, il filologo classico Vincenzo Ciaffi, lo studioso di lingue e culture germaniche Vittorio Amoretti e il romanziere Seborga che frequentava anche a Bordighera e che lo indirizzerà alle letture di Artaud
La stesura di Laborintus
Nel 1951 Sanguineti inizia a scrivere l’opera che si chiamerà “Laborintus” e, come egli stesso dice nei Santi Anarchici, scrive per una piccola comunità di lettori: “Eravamo in cinque. E i miei quattro lettori erano una ragazza, un aspirante filologo classico e due altri studenti, uno di farmacia e l’altro di medicina”. Conosce intanto Enrico Baj che crea il manifesto della pittura nucleare e da vita al Nuclearismo. Il 1953 è l’anno della morte della madre ma anche quello dell’incontro con Luciana, che sposerà il 30 settembre del 1954. Sempre nel 1954, in occasione della recensione di Sanguineti sulla rivista torinese “Galleria” dell’Antologia critica del Novecento, conosce Luciano Anceschi che, dopo aver letto Laborintus decide di darlo alle stampe. Alcune poesie di Laborintus erano intanto apparse su “Numero”, una rivista fiorentina diretta da Fiamma Vigo, alla quale era stato invitato a collaborare da Gianni Bertini, un pittore pisano incontrato da Sanguineti nello studio di Galvano Della Volpe.
 1956-1960: la pubblicazione, la laurea, la carriera universitaria
1956-1960: la pubblicazione, la laurea, la carriera universitaria
Il 1956 è l’anno della pubblicazione, a cura di Luciano Anceschi, di Laborintus ed anche l’anno della laurea. Sanguineti infatti, che era iscritto presso l’Università di Torino alla Facoltà di Lettere, il 30 ottobre discute una tesi su Dante con il professor Giovanni Getto, tesi che verrà pubblicata nel 1961 con il titolo Interpretazione di Malebolge. Nasce in quel periodo «Il Verri» redatto da Pagliarani e da Porta al quale Sanguineti collabora intensamente. Il 1º novembre 1957 Sanguineti si offre come assistente volontario presso la cattedra di Getto, insegnando contemporaneamente italiano nel triennio del liceo classico di un istituto privato diretto da suore domenicane.
1961-1965: i Novissimi e la libera docenza
Risale al 1961 la conoscenza da parte del poeta di Luciano Berio che gli chiede di collaborare per la Piccola Scala con una anti-opera. Nascerà da questa collaborazione Passaggio che verrà rappresentato nel 1963. Sempre nel 1961 esce l’antologia dei Novissimi con prefazione di Giuliani che comprende le opere di Giuliani stesso, di Sanguineti, di Pagliarani, di Balestrini e di Porta. Nel 1963 si istituisce il Gruppo 63 a Palermo che sarà “il risultato dei legami e dei contatti culturali maturati nei precedenti anni”. Nel frattempo Sanguineti, che era diventato assistente incaricato e in seguito assistente ordinario del professor Giovanni Getto, nel 1963 consegue la libera docenza e ha come presidente di commissione Mario Fubini. In questo periodo frequenterà, in tre occasioni, anche le Décades di Cerisy: la prima volta invitato da Ungaretti, al quale era dedicato il convegno, la seconda volta invitato dal gruppo di Tel Quel, per il romanzo sperimentale e, alla fine degli anni sessanta, per il cinema. Nel 1965 otterrà una cattedra di Letteratura italiana moderna e contemporanea presso la facoltà di lettere dell’università di Torino.
Il 1968: anno di cesura
Nel 1968 si scioglie il Gruppo 63 (e nel ’69 termineranno anche le pubblicazioni della rivista “Quindici”). Nello stesso anno Sanguineti si candida alle elezioni per la Camera nelle liste del PCI ma deve trasferirsi a Salerno con la famiglia come incaricato all’università. A Salerno Sanguineti terrà due corsi, quello di Letteratura italiana generale e quello di Letteratura italiana contemporanea e nel 1970 diventerà professore straordinario.
1971-1974: cambiamenti
Nel 1971 il poeta vive per sei mesi a Berlino con la famiglia, nel 1972 muore il padre, nel 1973 nasce la figlia Giulia e diventa, sempre a Salerno, professore ordinario. Nello stesso anno inizia la collaborazione a “Paese Sera”. Nel 1974 ottiene una cattedra di Letteratura italiana presso l’Università di Genova dove si trasferisce con la famiglia e nel 1975 inizia a collaborare con il “Giorno”.Nel 1976 Sanguineti inizia a collaborare con l'”Unità”, e nel 1980 con il “Lavoro” di Genova. Sono questi anni di grande impegno politico: viene infatti eletto consigliere comunale a Genova (1976 – 1981) e deputato della Camera (1979 – 1983), come indipendente nelle liste del PCI.Dal 1981 al 1983 dirige la prestigiosa rivista Cervo Volante assieme ad Achille Bonito Oliva. In redazioni ha giovanissimi poeti di talento come Valerio Magrelli e Gian Ruggero Manzoni. Numerosi sono i viaggi fatti in questo periodo sia in Europa che fuori dell’Europa (Unione Sovietica, Georgia e Uzbekistan, Tunisia, Cina, Stati Uniti, Canada, Messico, Colombia, Argentina, Perù, Giappone, India). Nel 1996 viene nominato dal presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine di gran merito della Repubblica Italiana.
La poesia di Sanguineti
La prima pubblicazione di Laborintus, nel 1956, nella collezione “Oggetto e simbolo” diretta da Luciano Anceschi per la casa editrice Magenta, passa quasi inosservata. Le sue poesie, così difficili e illeggibili, sarebbero divenute, solo un decennio dopo, norma per le sperimentazioni linguistiche-poetiche che avrebbero imperversato negli anni sessanta. Pasolini in un articolo su “Il Punto” definisce la raccolta Laborintus “un tipico prodotto del neo-realismo post-ermetico” al quale Sanguineti replica sul n. 11 di “Officina” nel novembre del 1957 con un articolo intitolato Una polemica in prosa ironizzando su le giuste distanze che Pasolini metteva tra il proprio “sperimentalismo” e quello “non puro sperimentalismo sanguinetiano”. La questione verrà ripresa da Luciano Anceschi sulla rivista Il Verri nel 1960 con questa affermazione:”Accade in questi anni – e vogliamo mettere come data di inizio del movimento il 1956? – nel nostro paese qualche cosa di naturale, di prevedibile, di necessario: nasce probabilmente una nuova generazione letteraria”‘.
Laborintus è infatti un testo di riferimento centrale per lo sperimentalismo degli anni sessanta soprattutto se confrontato con la poesia del suo tempo. Si presenta infatti come qualcosa di nuovo che apre soluzioni linguistiche e formali sconosciute a quella poesia che, nella seconda metà degli anni cinquanta, dopo lo spegnersi del neorealismo si stava orientando verso l’antinovecentismo introdotto all’interno della rivista “Officina”. Sanguineti, nel programma della neoavanguardia, è figura centrale per il suo poundismo, per i richiami psicoanalitici dei suoi testi, per il suo plurilinguismo e per quel verso pronto a dilatarsi in “un recitativo drammatico dove la soluzione metrica è rigorosamente atonale e, si potrebbe dire, gestuale”, come scriveva Giuliani. La poesia di Laborintus sembra, con la sua accentuata disgregazione dei linguaggi, rifarsi alle esperienze musicali di un Berio o di un Cage e, nell’ambito pittorico, all’informale Pollock, Fautrier o Rothko. La tecnica dell’assemblage, utilizzata nella poesia di Sanguineti, è infatti presa dall’ambito pittorico e gli oggetti – segni, tolti dallo spazio in cui erano collocati, acquistano improvvisamente la loro piena autonomia, ingrandendosi a dismisura.
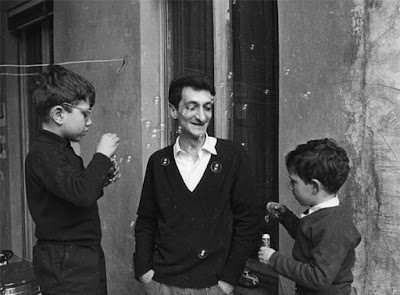 Sanguineti prosegue, dopo Laborintus, con lo stesso stile ipercolto e sovraccarico e scrive, tra il 1956 e il 1959 le poesie di tema erotico che vanno sotto il nome Erotopaegnia, poi, tra il 1960 e il 1963, Purgatorio de l’Inferno e nel 1964 raccoglie, sotto il titolo di Triperuno, le precedenti sequenze precedute da Laborintus. Ma in queste poesie già si possono notare dei movimenti verso una scrittura che si sposta dall’intellettualismo dei primi esordi alla concretezza delle cose quotidiane e che, in alcuni punti, si aprono al diarismo dei successivi libri.
Sanguineti prosegue, dopo Laborintus, con lo stesso stile ipercolto e sovraccarico e scrive, tra il 1956 e il 1959 le poesie di tema erotico che vanno sotto il nome Erotopaegnia, poi, tra il 1960 e il 1963, Purgatorio de l’Inferno e nel 1964 raccoglie, sotto il titolo di Triperuno, le precedenti sequenze precedute da Laborintus. Ma in queste poesie già si possono notare dei movimenti verso una scrittura che si sposta dall’intellettualismo dei primi esordi alla concretezza delle cose quotidiane e che, in alcuni punti, si aprono al diarismo dei successivi libri.
Nella seconda raccolta del 1972, Wirrwarr (confusione) che si compone di due parti, “Testo di appercezione tematica” (1966 – 1968) e “Reisebilder” (1971)(immagini di viaggio), il poeta pur continuando l’opera di destrutturazione del linguaggio che aveva iniziato con Triperuno, cerca di recuperare le cose autentiche del reale e del vissuto. Lo stile si fa più discorsivo e comunicativo, carattere questo che si ritrova nelle sue seguenti raccolte Postkarten (cartoline postali) del 1978, Stracciafoglio del 1980 e Scartabello del 1981 dove si impone un linguaggio più articolato che gioca su un registro parodico-ironico e si applica alle piccole cose della vita quotidiana. In queste raccolte l’avanguardia di Sanguineti, pur senza contraddirsi o negarsi, non appare, paradossalmente, lontana da situazioni come quelle di Giudici o Montale in opere come La vita in versi e Satura.
In seguito, periodicamente Sanguineti raccoglie i suoi versi in volumi riassuntivi, come Catamerone del 1974, ripreso nel 1982 in Segnalibro dove la sperimentazione si riappropria dell’uso della forma tradizionale per approdare, nel 1986, a Novissimum Testamentum, poi incluso in Senzatitolo nel 1992. In queste opere il poeta si impegna, confermando così la sua attenta ricerca metrica, sull’ottava, sulla canzonetta, sul sonetto intervallandoli con componimenti dal tipico verso extra-lungo che sembra scivolare via e “frantumarsi”.
Nel 1987 esce la raccolta Bisbidis che costituisce un capitolo aggiuntivo nella linea iniziata con Wirrwarr. Il titolo, che è ripreso da una frottola del poeta Immanuel Romano (contemporaneo di Dante), è una voce onomatopeica che indica il chiacchierio di gente e appare come poesia di carattere colloquiale quasi crepuscolare che conferma quella linea poetica iniziata negli anni Settanta.
Del 2002 è la raccolta Gatto Lupesco che contiene Bisbidis, Senzatitolo, Corollario, la versione definitiva di Cose, e una sezione di poesie intitolate Poesie fuggitive. Del 2004 è la raccolta antologica Mikrokosmos Poesie 1951-2004 che si presenta divisa in due parti. La prima parte comprende una scelta di Laborintus, di Erotopaegnia,di Purgatorio de l’Inferno, di T.A.T.,di Reisebilder, di Postkarten, di Stracciafoglio, di Scartabello, di Cataletto, di Codicillo, di Rebus, di Glosse, di Corollario e di Cose. La seconda parte comprende una selezione da Fuori Catalogo, da L’ultima passeggiata, omaggio a Pascoli, da Alfabeto apocalittico, da Novissimum Testamentum, da Ecfrasi, da Mauritshuis, da Ballate, da Fanerografie, da Omaggio a Catullo, da Stravaganze, da Poesie fuggitive, da Varie ed eventuali.
Anche nel romanzo Sanguineti dedica molta attenzione al trattamento del linguaggio, tanto sul piano lessicale quanto su quello sintattico e sia nel romanzo Capriccio italiano, pubblicato nel 1963, e Il gioco dell’Oca del 1967 si avverte il piacere ludico della parola. La sua produzione narrativa è stata raccolta in “Smorfie”, contenente i due romanzi oltre ad altri testi in prosa. Ed è con Capriccio italiano che lo scrittore si fa portavoce del romanzo sperimentale mostrando la crisi del romanzo tradizionale giocando sui motivi dell’inconscio, dell’onirico e del biologico – sessuale. Il tema centrale del romanzo si basa sulla gravidanza della moglie del narratore e l’attesa del figlio ed è trattato non in modo naturalistico ma come una prova che, attraverso brevi episodi simili ad un sogno, smuovono gli strati dell’inconscio.
Fonte: wikipedia
8 commenti
La poesia di Sanguineti era molto particolare. Mi ricordo che, un giorno, stavo leggendo delle strofe di poeti moderni, la maggiora parte dei quali non è che mi piacesse. Infatti, tante volte, per colpire l’interesse del lettore, queste persone mettono insieme delle parole senza senso.
Così sembrava anche sanguineti, ma non era vero.
Infatti, mi ha ispirato una delle mie poesie che più mi piacciono e che ho dedicato a lui, tanto più oggi che non c’è più:
…. E vorrei poter liberare
la mente per lasciarla giocare
con le parole, con i sogni,
con i desideri.
E lasciarla sfogare,
divertendosi liberamente
con tutto ciò che più le piace;
evitando tutto ciò che la
costringa, che non le dà pace.
Si ritroverebbe ai tempi
dell’infanzia,
quando tutto era più
semplice, puro, sereno.
E potrebbe godere
lasciandomi libera
di volare con lei,
accompagnate
da una dolce melodia.
29/11/2000
Spero vi piaccia.
Buongiorno Alessandra,
grazie di cuore per il tuo intervento sul nostro sito. La tua poesia ci è piaciuta molto: è intensa e traspira il senso della poetica di un grande intellettuale italiano che tanto ha dato al suo paese. Un intellettuale che viveva nella società civile, attento ai diritti civili e al senso dell’essere “cittadino”. E allo stesso tempo, difendeva i valori individuali e il piacere di essere semplicemente “uomo”, con i suoi difetti, i suoi pregi, i suoi sogni.
Ringraziamo tutti con commozione Eduardo Sanguineti, ringraziamo te per avere voluto condividere con noi e con tutti i lettori di medeaonline un momento della tua vita personale e poetica. Grazie.
La Redazione di medeaonline
Parole senza pretese per condividere il ricordo di un poeta che ha lasciato, quale lui riteneva fosse il compito dei poeti,una traccia indelebile nella sua epoca.
Perché mi accorgo che morire adesso non serve
non serve no
di rincorsa
a parole
sdrucciole
camuffe
eppure salde
fra gradini scivolosi
fra assonanze
e
dissonanze
magiche
come magico è un cogliere di mele
fra rami
dove l’apparenza è
il nonsenso
e dove stranamente
la collocazione
rende giustizia
a strofe
senza
fine
come note
slegate
che precipitano
giù
e rendon melodia
il loro cadere
Antonella Borghini
chiedo scusa ma il pc ha saltato una parte della dedica rendendo errato il mio pensiero.
Benedetta tecnologia..:-)
Aggiungo il mio pensiero completo.
Parole senza pretese, le mie, per condividere il ricordo di un poeta che ha lasciato una traccia indelebile di “giocoliere della parola”. Un grande poeta, che ha saputo ben delineare l’ideologia della sua epoca, così come lui riteneva fosse il compito della poesia, oggi.
MUTA MUSA DI SETTEMBRE: di Salvatore Fittipaldi (per Edoardo Sanguineti)
pubblicata da Salvatore Fittipaldi il giorno mercoledì 20 ottobre 2010
.
..la tresca…
per la tua estate (inesistente) volevo scrivere un giardino
di parole (con tanti due punti, virgole, parentesi):
volevo (appunto) scriverlo (in lingua viva) un cantico
(con tanto d’appendice, corollario, note): e ci volevo mettere
(così com’è che è) la tresca delle nostre anime:
e l’urgenza dell’acqua sopra i fiori: e i fiori nell’acqua
dei tuoi occhi (senza metafore, senza digressioni):
per la tua estenuante estate, volevo poetare un’estasi
(con estetiche ed estese strofe) a cui volevo aggiungere
un abbraccio forte (alla disperazione) e la delicata risorsa delle lacrime:
volevo solo questo, per la tua (triste) estate (d’afa, fatiche e affanni):
***
…il desiderio…
mi espongo (qui davanti a tutti: mi spingo oltre) e te le espongo
(esposizione e impaginazione a cura dell’autore) intensamente pensandoti
le mie seghe compositive, le mie disturbazioni e macerazioni mentali:
(oggi, martedi 7, stanza 121, pausa telemetria): riassumendo,
brevemente (appunto): per dirtelo: mettere in luce: a che punto
scatta (invece) per me, il desiderio (pratica che seguo e inseguo
solo teoricamente, puntualmente, a puntino, da qualche tempo per te):
mi svergogno (qui, davanti a tutti): schiocco le mani,
richiamo l’attenzione e grido (forte): -Desidero sentire la tua voce!-
***
…la copula…
ti sono (mi sei) accanto, tanto (con la dialettica della mia mente:
con i miei elaborati erotici): senza sottintesi: senza:
ci siamo accanto ( in copula poetica: tra asindeti e aferesi)
tu con il tuo silenzio, io con qualche dubbio:
ti sono: in modo molto semantico e romantico
(tra il dialogico e il non logico): ti sono (molto: troppo, forse)
nell’involucro di un testo metafisico (del mio ridicolo fisico,
praticamente evanescente, etereo: tra il presente e l’assente):
ti sono accanto, con le mie parole, con il mio pianto
(tu di lato, io di fianco: in un prato, in un cespuglio
a letto, su un tappeto: e lì ti sciolgo un fiocco, con due dita:
***
…la colpa…
la mia colpa è la sincerità: la mia tacca, la mia pecca,
il mio peccato: non ammettere che fingere è la salvezza:
devo dimessamente (e incoscientemente) ammettere
(un po’ per convenienza) che la colpa in questione mi accusa
e mi incolpa: (la cosa è molto chiara: così come è chiaro
che mi prendo anche la colpa): e che il medesimo stesso errore,
mio, di me medesimo stesso, è un errore di distrazione
non di giudizio: un errore di vecchiaia (che già mi fu
di gioventù, probabilmente):
la mia colpa sono le mie bugie:
Grazie per i tuoi versi, Salvatore. Siamo felicissimi che Medea possa essere un’occasione per uno scambio poetico tra anime sensibili. Tra le persone che commentano questo articolo innanzitutto e tra noi tutti ed Edoardo Sanguineti, cui saremo sempre infinitamente grati
Il mio tutto: di S. Fittipaldi
pubblicata su Facebook da Salvatore Fittipaldi il giorno lunedì 15 novembre 2010 alle ore 0.39
io vivo nel mio tutto e poco e niente
nelle lacune e le mancanze della mente:
vivo dentro al mio corpo inconsistente
insieme al dopo al durante e al precedente:
vivo coi miei principii e i miei teoremi
nel centro del mio cerchio quasi ovale:
vivo nella metafora oggettuale
come se nulla già mi è stato mai:
vivo nel mio universo molto e spesso
con i miei schemi empirici e irreali:
io stesso trovo questo assai grottesco:
vivo nel mio castello di Kronberg
sopra all’eterno equivoco nou-fenomenico:
ma qui ci mangio e dormo e niente più:
Vi ricordo che il 9 dicembre l’amico Edoardo avrebbe compiuto 8o anni: auguri comunque!!!!!